
Rossana Cetta: la scuola deve educare al nuovo umanesimo
Intervista all'autrice, per 44 anni insegnante e 'protagonista in corpore vivo della scuola, come di un luogo vissuto e amato giorno per giorno. . . .'
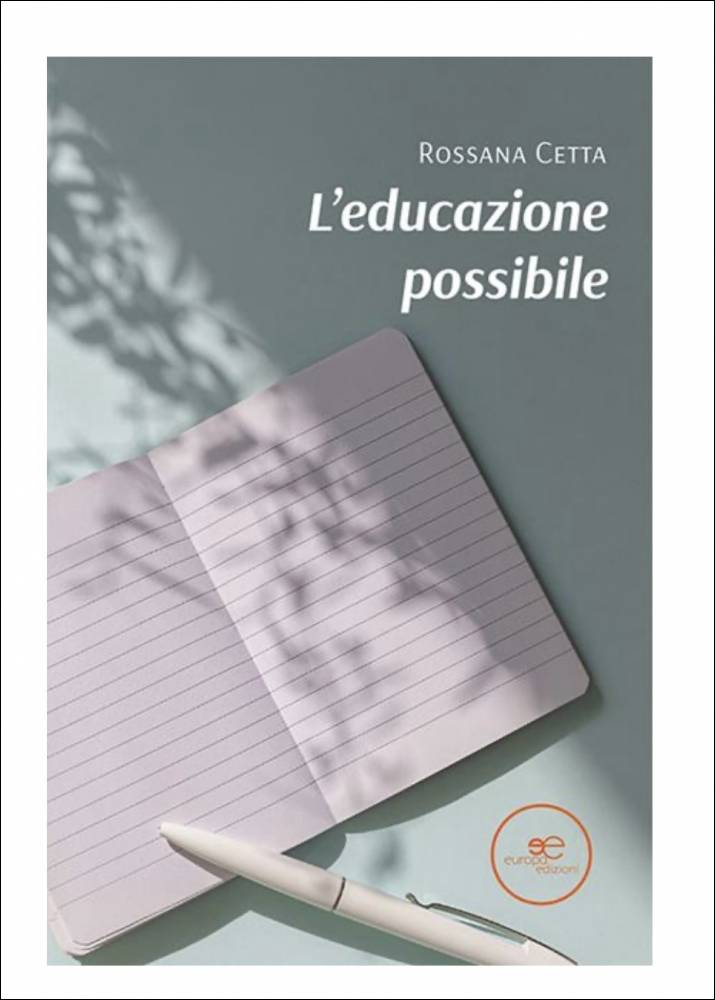 Sabato, 22/02/2025 -
Sabato, 22/02/2025 -
L’educazione possibile, è il secondo libro dedicato alla scuola, di Rossana Cetta, insegnante di materie letterarie e latino per 44 anni, presso il liceo scientifico Aeclanum di Mirabella Eclano. L’autrice, oggi in pensione, parla da “protagonista in corpore vivo della scuola, come di un luogo vissuto e amato giorno per giorno, di cui si conoscono gli angoli bui e le finestre che si vorrebbero metaforicamente aprire, per far entrare luce e aria nuove”, riprendendo la prefazione di Gerardo Vespucci. Donna vivace dai plurimi interessi, Rossana è originaria di Sant’Angelo dei Lombardi, ma vive a Grottaminarda (AV), dove l’ho incontrata: mi ha espresso le preoccupazioni per l’involuzione della scuola, la generale mancanza di cultura e senso critico, nonché di rispetto per il diverso, elementi prioritari per costruire un buon futuro.
Partiamo da ruolo e responsabilità dell’insegnante, oggi…
In questi tempi sciagurati, in cui prevale un relativismo che annichilisce, a volte sembra svilito anche il ruolo dell’insegnante, mentre mai come oggi, è centrale per le nuove generazioni. Romano Luperini, critico insigne della letteratura, ha spesso ribadito che, compito degli insegnanti è traghettare i giovani verso un nuovo umanesimo. La scuola ha una grande responsabilità nell’educazione dei ragazzi e deve perciò darsi delle regole, soprattutto quando la famiglia non è in grado di farlo. Ritengo (da desanctisiana convinta) che l’educazione non debba essere disgiunta dall’istruzione: tutti i docenti devono farsi carico, soprattutto con l’esempio, di principi ineludibili di democrazia e di convivenza civile. Dal canto suo, la scuola deve riappropriarsi della regola fondamentale basata su premio e punizione, basilare a ogni processo di apprendimento. Attualmente invece, si registra troppo laissez-faire: pensiamo all’uso dei cellulari in classe, per esempio… I ragazzi hanno sempre ragione, anche quando eludono le regole più elementari.
Serve una nuova architettura per gli spazi di apprendimento e chi dovrebbe proporla?
Il problema ricade in primis sul ministro dell’Istruzione, che dovrebbe avere una visione chiara sulla scuola del futuro prossimo e in secondo luogo, sui dirigenti scolastici. Si dovrebbe anzitutto sciogliere finalmente l’enigma sull’autonomia della scuola, che non gode affatto di piena autonomia. Sembra infatti che i dirigenti non possano modificare in piena libertà gli spazi interni, né immaginare una nuova architettura degli edifici. Io avevo immaginato per la mia scuola una biblioteca di facile accesso, con piccoli scaffali nei lunghi ed ampi corridoi, con sedie e tavolini in ogni angolo, cosicché i ragazzi, uscendo dalle aule nei momenti di noia, potessero leggere liberamente qualcosa, oppure ascoltare musica. Ma la mia è pura utopia!
Cosa sta portando alla lenta, ma inesorabile agonia della scuola?
La scuola ha perso la sua identità da quando il pedagogismo neoliberale ha imposto i suoi dogmi, mettendo la scuola in relazione al contesto socio-economico e riducendo la formazione umana al saper fare richiesto dal mercato. Sono saltati tutti i parametri su cui si reggeva la pedagogia tradizionale. Basti pensare alle feroci critiche rivolte alla lezione ex cathedra, al tema in classe, alla riduzione delle ore nelle materie fondamentali, ai compiti a casa. Sono stati gradualmente scardinati pilastri importanti per assicurare una preparazione culturale solida. Inoltre, i ragazzi sono ormai abituati al “tutto facile e subito” ed hanno tanti altri impegni nel pomeriggio, cosicché la scuola passa in second’ordine. Oltretutto, essa non rappresenta più un ascensore sociale, dato che arriva al successo professionale chi ha più soldi e genitori che contano.
Come si è arrivati all’attuale massificazione e appiattimento culturale?
Temo che la politica abbia fatto qualche danno. Preciso che non sono contraria al diritto allo studio per tutti, ma la massificazione, che non è da ritenersi il contrario di scuola selettiva, ha fatto sì che i contenuti disciplinari venissero in qualche modo adeguati al livello di un pubblico di massa e quindi ridotti, se non banalizzati. In breve: la scuola si è adeguata al pubblico, anziché creare un pubblico.
È utile l’alternanza scuola-lavoro (PCTO) o piuttosto, controproducente?
Nelle scuole tecniche e professionali l’alternanza scuola/lavoro è molto importante ed è sempre stata obbligatoria, sebbene anche in queste realtà debba sempre prevalere la formazione umana. Nei licei, io non l’ho mai accettata, mi è sembrata sin da subito una violazione al tempio della cultura, uno spreco di tempo sottratto alla didattica e alla conoscenza. Mi sono sempre chiesta perché non lasciare la libera iniziativa alle famiglie, che da sempre nel periodo estivo hanno consentito ai ragazzi di fare una breve esperienza lavorativa. Bastava rendere obbligatorio un tirocinio nel periodo estivo in un’azienda liberamente scelta. Nel libro ho ribadito più volte che il ruolo delle conoscenze è ormai diventato strumentale all’acquisizione di abilità spendibili sul mercato e questo è scandaloso, se pensiamo all’ignoranza che imperversa ovunque. Così si crea una scuola ibrida, che né forma né insegna.
Come si esce dall’attuale empasse?
Oggi si parla di introdurre nelle scuole l’educazione sessuale e sentimentale, fra le tante, troppe, educazioni, che già ricadono sulla scuola, direi alla latina: corruptissima Republica, plurimae leges. Per arginare il degrado educativo dei nostri giovani, basterebbe recuperare l’idea originaria di scuola di Francesco De Sanctis,che la intendeva non come un luogo di nozioni e precetti, bensì come una fucina d’intelletti, un centro formativo della gioventù italiana, capace di forgiare volontà e forze morali,utili al progresso del Paese. Gli studi umanistici e lo studio della letteratura nell’ottica desanctisiana, assumono un ruolo centrale, giacché provvedono all’educazione del cuore. Solo la letteratura può innestare nel cuore dei giovani valori di rettitudine morale e nobili sentimenti.
Perché le ragazze scelgono ancora poco le materie scientifiche?
È un problema culturale, serve un’inversione di tendenza, che non può prescindere da una nuova mentalità che includa le donne in ogni settore, a partire dalle materie STEM, per le quali le donne hanno ampiamente dimostrato di essere più che portate.
Rossana Cetta
L’educazione possibile
europa edizioni / pagg.111 / € 13,90
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®


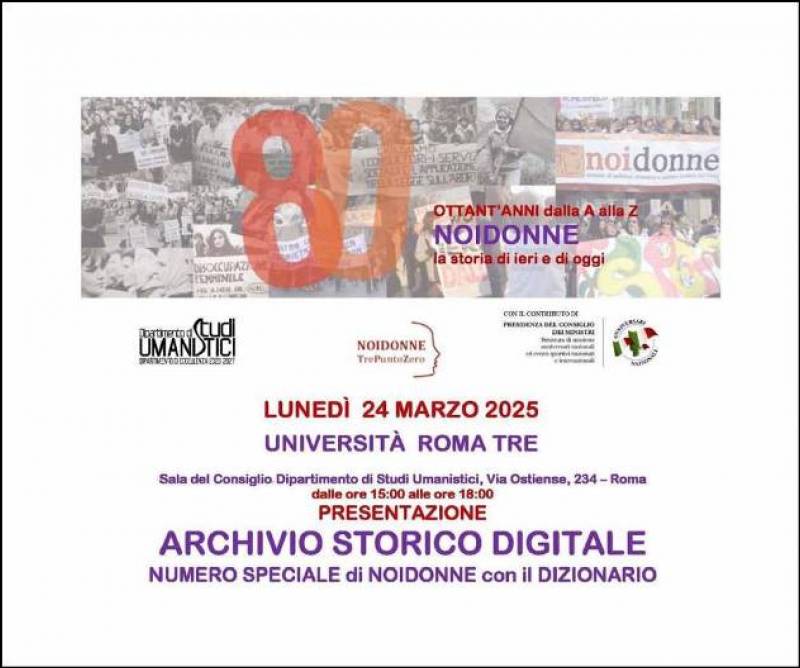

Lascia un Commento