
I divieti e la resistenza delle donne
Parliamo di Bioetica - La cultura patriarcale associa il carattere femminile alla docilità e alla sottomissione e le donne tendono ad interiorizzare un modello di passività
Battaglia Luisella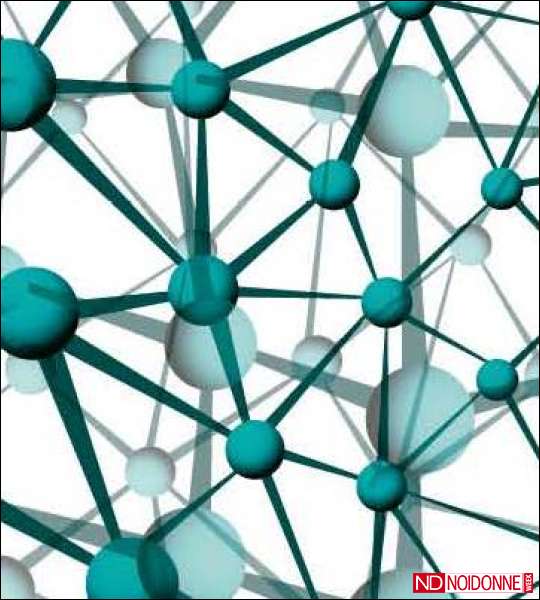 Lunedi, 10/10/2016 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2016
Lunedi, 10/10/2016 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2016
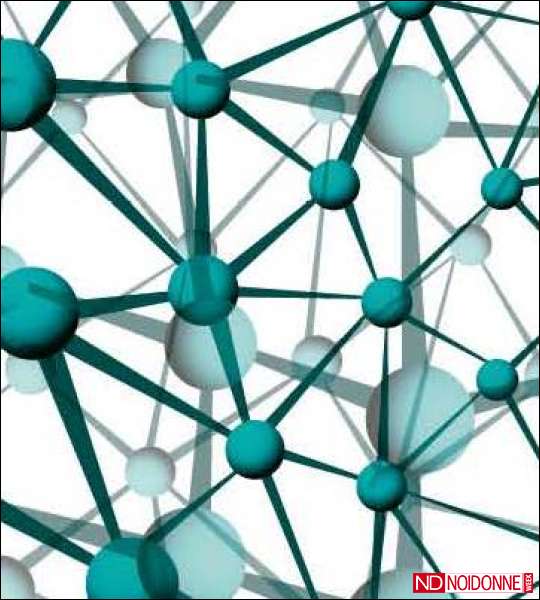 Lunedi, 10/10/2016 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2016
Lunedi, 10/10/2016 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Ottobre 2016“Le donne libere diventeranno la nostra bandiera”. Queste le parole con cui lo scrittore Marek Halter, da tempo impegnato per promuovere la pace in Medioriente, ha commentato le immagini delle siriane di Manbij. Ecco una donna che si toglie il velo, un’altra che abbraccia una militante kurda in divisa, una donna anziana che chiede una sigaretta e fuma ostentatamente, non certo per il desiderio di fumare ma perché intende disobbedire a un divieto che avrebbe comportato un tempo una punizione esemplare. Le immagini che scorrono davanti ai nostri occhi non potrebbero essere più esplicite: ci parlano di una vera e propria sfida ai divieti imposti da un ordine patriarcale ormai violato. Gesti, dunque, di autentica ribellione che mi hanno richiamato alla mente le parole con cui una celebre psicologa, Carol Gilligan, nel suo testo più recente, La virtù delle resistenza, invita le donne a coltivare una virtù oggi, anche nel nostro paese, particolarmente necessaria. Il suo appello è, appunto, di resistere, di non cedere. Per troppo tempo il carattere femminile è stato associato a tratti quali la passività, la docilità, la sottomissione: una vera e propria ‘iniziazione sociale’ che induce, fin da adolescenti, ad interorizzare un modello di femminilità che spinge al conformismo e, talora, al sacrificio dei propri diritti, anziché all’apertura mentale e al pensiero critico.
La splendida frase finale di Re Lear: “dire quello che sentiamo dentro, non quello che dovremmo”, più volte citata, diviene in tal senso emblematica del suo invito a rifiutare un’iniziazione che comporta il sacrificio del mondo delle emozioni e dei sentimenti in nome di un’idea astratta di ragione. Resistere alle dicotomie prescritte e imposte socialmente - ragione ed emozione, mente e corpo, sé e relazioni - significa tuttavia manifestare una voce che non è necessariamente piacevole e può creare problemi in famiglia, nella scuola e nella comunità. Di conseguenza le ragazze tendono a soffocarla, vivendo un forte conflitto tra la loro capacità intuitiva e una cultura che vieta loro di essere intuitive, tra l’empatia e il desiderio di relazioni e una società che premia l’autosufficienza.
Perché le donne sono chiamate alla resistenza? Contro chi? In nome di che cosa? “Resistere, prendersi cura, non cedere”. Il sottotitolo del libro indica chiaramente il carattere militante dell’opera e la crucialità del tema della cura come asse portante dell’intera argomentazione. Da qui l’invito alla “resistenza” da intendersi nei suoi molteplici significati: resistenza al disagio, resistenza politica, che è dire la verità di fronte al potere - e Gilligan è memore del peso della disubbidienza civile nella tradizione anglosassone, a partire da Thoreau, fino ai movimenti di protesta degli anni ’60 e ‘70 - ma anche resistenza nella sua accezione psicoanalitica, che implica la resilienza, la capacità di amare e vivere preservando la propria integrità contro le scissioni caratteristiche della logica binaria del patriarcato. È infatti nell’adolescenza che le ragazze subiscono le maggiori pressioni a considerare la voce del padre come la voce stessa dell’autorità morale e a vivere secondo tale legge. Se la capacità di sentire l’altro è innata, tale capacità dovrà essere sminuita o, quanto meno, relegata ai margini: questo è il compito dell’iniziazione al patriarcato che, se riesce, impianta nella psiche comportamenti estranei alla loro natura. Ragazze più resilienti resisteranno alle pressioni per separare le loro menti dai loro corpi, i pensieri dalle emozioni, se stesse dalle relazioni; altre, più timorose, soffocheranno quella voce autentica che nella nostra cultura non ha la dignità di essere, commettendo quello che Virginia Woolf chiama “l’adulterio del cervello”, intendendo con ciò il tradimento del proprio pensiero.
Vi è anche chi, come la psicoanalista Teresa Bernardez, è giunta a parlare di un recupero della rabbia. In Women and Anger sottolinea, infatti, che la condanna culturale della rabbia si è tradotta per le donne in una inibizione psicologica che impedisce atti di ribellione, con il risultato di renderle complici della loro miseria. Se messa a tacere, concorre all’insorgere della depressione, mentre la sua manifestazione appare come “la risposta cosciente di fronte all’ingiustizia subita e ai lutti sostenuti”. Ebbene, appare ispirato ad un’autentica rabbia il gesto di una donna coraggiosa - la cui immagine è stata trasmessa dal telegiornale - che calpesta il burka gridando:”Noi non abbiamo onore? Noi siamo gente d’onore!”. A significare che l’onore sta nella propria dignità finalmente rivendicata.
Qualcosa sta dunque cambiando. Queste immagini ci parlano di “donne che diventano persone”: in troppi paesi esse sono ancora prive dei mezzi di sostegno indispensabili all’esercizio di funzioni fondamentalmente umane, non godono di piena eguaglianza di fronte alla legge, non possiedono gli stessi diritti - di proprietà, di stipulare contratti, di associazione, di movimento - di cui godono gli uomini.
Contro gli eccessi del relativismo culturale, che in nome delle tradizioni giustifica le peggiori oppressioni - dalla violenza domestica alle mutilazioni genitali - dovremmo allora ricordarci che i costumi culturali non possono andare contro i modelli generali di giustizia. Rispettare le persone significa criticare la tradizione che le opprime, le tratta con disprezzo e nega loro i diritti civili e politici.
Si è più volte affermato che le donne sono il cardine del possibile cambiamento dell’Islam: in effetti, nella loro condizione si riflettono, con particolare evidenza, le contraddizioni della modernizzazione, specie i conflitti tra i vecchi costumi e i nuovi diritti. In tal senso esse rappresentano una forza di cui in Occidente non siamo sempre consapevoli e che occorrerebbe sostenere in una prospettiva davvero universalistica.
Per questo le siriane di Manbij devono essere ascoltate nel loro insopprimibile desiderio di libertà e diventare “la nostra bandiera”. Penso ad un’altra immagine in cui le donne avanzano a volto scoperto tenendo in braccia due bimbi in fasce. Un’immagine, certo, di cura materna ma anche di speranza in un avvenire in cui la cura possa diventare un valore di tutti, riassumendo il significato centrale che dovrebbe avere nella nostra vita.
La splendida frase finale di Re Lear: “dire quello che sentiamo dentro, non quello che dovremmo”, più volte citata, diviene in tal senso emblematica del suo invito a rifiutare un’iniziazione che comporta il sacrificio del mondo delle emozioni e dei sentimenti in nome di un’idea astratta di ragione. Resistere alle dicotomie prescritte e imposte socialmente - ragione ed emozione, mente e corpo, sé e relazioni - significa tuttavia manifestare una voce che non è necessariamente piacevole e può creare problemi in famiglia, nella scuola e nella comunità. Di conseguenza le ragazze tendono a soffocarla, vivendo un forte conflitto tra la loro capacità intuitiva e una cultura che vieta loro di essere intuitive, tra l’empatia e il desiderio di relazioni e una società che premia l’autosufficienza.
Perché le donne sono chiamate alla resistenza? Contro chi? In nome di che cosa? “Resistere, prendersi cura, non cedere”. Il sottotitolo del libro indica chiaramente il carattere militante dell’opera e la crucialità del tema della cura come asse portante dell’intera argomentazione. Da qui l’invito alla “resistenza” da intendersi nei suoi molteplici significati: resistenza al disagio, resistenza politica, che è dire la verità di fronte al potere - e Gilligan è memore del peso della disubbidienza civile nella tradizione anglosassone, a partire da Thoreau, fino ai movimenti di protesta degli anni ’60 e ‘70 - ma anche resistenza nella sua accezione psicoanalitica, che implica la resilienza, la capacità di amare e vivere preservando la propria integrità contro le scissioni caratteristiche della logica binaria del patriarcato. È infatti nell’adolescenza che le ragazze subiscono le maggiori pressioni a considerare la voce del padre come la voce stessa dell’autorità morale e a vivere secondo tale legge. Se la capacità di sentire l’altro è innata, tale capacità dovrà essere sminuita o, quanto meno, relegata ai margini: questo è il compito dell’iniziazione al patriarcato che, se riesce, impianta nella psiche comportamenti estranei alla loro natura. Ragazze più resilienti resisteranno alle pressioni per separare le loro menti dai loro corpi, i pensieri dalle emozioni, se stesse dalle relazioni; altre, più timorose, soffocheranno quella voce autentica che nella nostra cultura non ha la dignità di essere, commettendo quello che Virginia Woolf chiama “l’adulterio del cervello”, intendendo con ciò il tradimento del proprio pensiero.
Vi è anche chi, come la psicoanalista Teresa Bernardez, è giunta a parlare di un recupero della rabbia. In Women and Anger sottolinea, infatti, che la condanna culturale della rabbia si è tradotta per le donne in una inibizione psicologica che impedisce atti di ribellione, con il risultato di renderle complici della loro miseria. Se messa a tacere, concorre all’insorgere della depressione, mentre la sua manifestazione appare come “la risposta cosciente di fronte all’ingiustizia subita e ai lutti sostenuti”. Ebbene, appare ispirato ad un’autentica rabbia il gesto di una donna coraggiosa - la cui immagine è stata trasmessa dal telegiornale - che calpesta il burka gridando:”Noi non abbiamo onore? Noi siamo gente d’onore!”. A significare che l’onore sta nella propria dignità finalmente rivendicata.
Qualcosa sta dunque cambiando. Queste immagini ci parlano di “donne che diventano persone”: in troppi paesi esse sono ancora prive dei mezzi di sostegno indispensabili all’esercizio di funzioni fondamentalmente umane, non godono di piena eguaglianza di fronte alla legge, non possiedono gli stessi diritti - di proprietà, di stipulare contratti, di associazione, di movimento - di cui godono gli uomini.
Contro gli eccessi del relativismo culturale, che in nome delle tradizioni giustifica le peggiori oppressioni - dalla violenza domestica alle mutilazioni genitali - dovremmo allora ricordarci che i costumi culturali non possono andare contro i modelli generali di giustizia. Rispettare le persone significa criticare la tradizione che le opprime, le tratta con disprezzo e nega loro i diritti civili e politici.
Si è più volte affermato che le donne sono il cardine del possibile cambiamento dell’Islam: in effetti, nella loro condizione si riflettono, con particolare evidenza, le contraddizioni della modernizzazione, specie i conflitti tra i vecchi costumi e i nuovi diritti. In tal senso esse rappresentano una forza di cui in Occidente non siamo sempre consapevoli e che occorrerebbe sostenere in una prospettiva davvero universalistica.
Per questo le siriane di Manbij devono essere ascoltate nel loro insopprimibile desiderio di libertà e diventare “la nostra bandiera”. Penso ad un’altra immagine in cui le donne avanzano a volto scoperto tenendo in braccia due bimbi in fasce. Un’immagine, certo, di cura materna ma anche di speranza in un avvenire in cui la cura possa diventare un valore di tutti, riassumendo il significato centrale che dovrebbe avere nella nostra vita.
©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®





Lascia un Commento