
'Di spalle a questo mondo' di Wanda Marasco, romanzo candidato al Premio Strega 2025
Il dramma dell'imperfezione di Ferdinando Palasciano e di sua moglie Olga Pavlova Vavilova
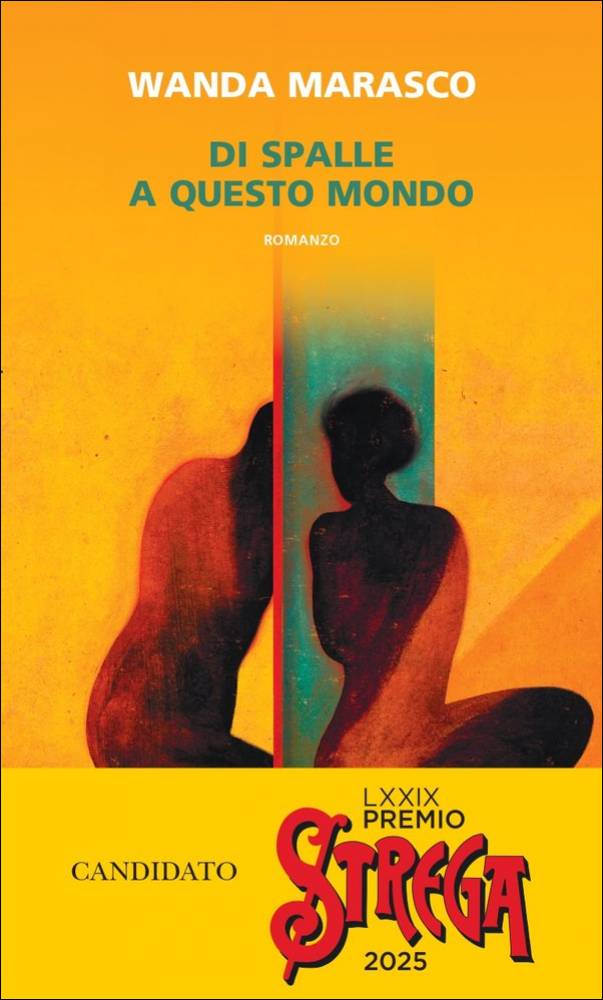 Mercoledi, 16/04/2025 - L’Empiria è un primo raccogliere e legare ciò che viene offerto dai sensi senza però coincidere con un vero e proprio processo creativo. Da una parte essa è sottomessa alla necessità di ordinare i fenomeni sensoriali e dall’altra non può raggiungere un ordine, ma solo un insieme un mondo disgregato di giustapposizioni: le sue constatazioni vengono raccolte senza raggiungere una totalità di senso. L’esperienza è solo il punto di partenza per acquisire la scienza e l’arte. Il livello del sapere come posizione della domanda inizia proprio a partire dall’apparire, senza ciò che appare è anche impossibile la domanda.
Mercoledi, 16/04/2025 - L’Empiria è un primo raccogliere e legare ciò che viene offerto dai sensi senza però coincidere con un vero e proprio processo creativo. Da una parte essa è sottomessa alla necessità di ordinare i fenomeni sensoriali e dall’altra non può raggiungere un ordine, ma solo un insieme un mondo disgregato di giustapposizioni: le sue constatazioni vengono raccolte senza raggiungere una totalità di senso. L’esperienza è solo il punto di partenza per acquisire la scienza e l’arte. Il livello del sapere come posizione della domanda inizia proprio a partire dall’apparire, senza ciò che appare è anche impossibile la domanda.Sapere e apparire hanno dunque la stessa origine.
Con una eco tipicamente heideggeriana l’apparire è inteso come un mostrarsi in forza propria, un venire in luce, un manifestare. L’esplicitazione del fenomeno è così affidata al logos, In tal senso l’uomo è parte del tutto, semplice espressione di tale ordinamento: in questa prospettiva l’interpretazione equivale all’espressione di un messaggio di cui l’uomo è portatore. La prima coscienza dell’uomo è mitica, una visione mitica del mondo. Ogni epoca storica nasce da una forma particolare di interpretazione, dai miti i quali non spiegano le leggi dello sviluppo dei fenomeni.
Tutto ciò che avviene sembra soggetto al nulla, non necessario, votato alla morte. Con Kieregaard potremmo dire “ogni divenire è un patire”.
Bisogna attraversare l’esperienza dolorosa degli eventi, per cui il conseguimento del sapere comporterà un approdo, ma il prezzo di una simile concezione è l’inevitabilità del dolore.
La realtà non solo diviene, ma il suo divenire è incessante domanda, rivolta dalla vita ad altra vita.
Con il romanzo 'Di spalle a questo mondo' (ed Neri Pozza) di Wanda Marasco, siamo con Palasciano dinanzi alla storia di una vita. La vera difficoltà riguarda la modalità dei legami di questa storia, difficoltà che Wilhelm Dilthey ha chiamato ‘la connessione della vita’ (Lebenszusammenhang). L’aporia consiste nel fatto che la riflessione ha a che fare con un concetto di identità che mescola i due significati della parola: l’identità del sé (l’ipseità) e l’identità del medesimo. “Identico” in quest’ultimo senso significa, come abbiamo appena detto, ‘estremamente simile, analogo’. Ciononostante, come potrebbe il sé restare il più simile possibile se non ci fosse in lui un qualche nucleo immutabile, sottratto al cambiamento temporale? Tutta l’esperienza umana testimonia però contro questa permanenza di un elemento costitutivo della persona: nell’esperienza interiore nulla sfugge al cambiamento. L’antinomia sembra nello stesso tempo inevitabile e insolubile: inevitabile, perché l’impiego del medesimo nome per designare una persona dalla nascita alla morte sembra implicare l’esistenza di questo nucleo immutabile, mentre l’esperienza del cambiamento corporeo e psichico contraddice tale ipseità; insolubile per il modo con cui è posta, cioè attraverso categorie che sono inadeguate al concetto di una connessione della vita.
Queste categorie sono state introdotte da Kant come “categorie di relazione”. La prima è la categoria della sostanza, cui corrisponde lo schema della «permanenza del reale nel tempo, ossia la rappresentazione del reale quale sostrato della determinazione empirica del tempo in generale; sostrato quindi che rimane, nel variare di tutto il resto». Sul piano del giudizio, a questa categoria e a questo schema corrisponde, come «prima analogia dell’esperienza», il principio della permanenza così definito: «tutti i fenomeni contengono il permanente (sostanza) come l’oggetto stesso, e il mutevole, come sua semplice determinazione, cioè il modo della sua esistenza». Il concetto di connessione della vita evidenzia però l’errore di questa definizione categoriale, che è valida solo all’interno di una assiomatica della natura fisica: non si riesce a capire quale regola consenta di pensare quella combinazione dipermanenza e non permanenza che sembrerebbe implicata dalla connessione della vita. Eppure abbiamo una certa intuizione di questa regola, nella misura in cui il concetto di coesione della vita orienta il pensiero verso una certa combinazione di segni di persistenza e segni di cambiamento. Ed è proprio a questo punto che il racconto offre la sua mediazione: si tratta ora di mettere in evidenza come narrata e quindi all’identità dell’ipseità come si configura nell’atto della lettura. L’identità narrativa della costruzione dell’intreccio, la coordinazione tra la storia narrata e il supporto dell’intreccio – il personaggio – è stata formulata per la prima volta da Aristotele nella Poetica. Aristotele definisce questa coordinazione così strettamente da farle assumere i tratti di una subordinazione. All’interno della storia narrata così come nell’unità e integrità che le sono proprie e che provengono dalla costruzione dell’intreccio, per tutta la storia il personaggio conserva la propria identità, che si trova in correlazione con quella della storia narrata. Il romanzo moderno non distrugge del tutto questa correlazione, come attesta Frank Kermode formulando l’assioma secondo il quale per sviluppare un personaggio romanzesco bisogna raccontare di più.
Ecco perché è prima di tutto nella costruzione dell’intreccio che dovremo cercare la mediazione tra permanenza e cambiamento, prima che nel personaggio.
Con “concordanza” intendo un principio ordinativo che presiede a quello che Aristotele chiama l’«intreccio dei fatti». La concordanza ha tre caratteristiche: completezza, totalità (il tutto), estensione appropriata. Con completezza dobbiamo intendere l’unità della composizione che esige che l’interpretazione di una parte sia subordinata all’interpretazione del tutto. Quanto al tutto, dice Aristotele, «è ciò che ha un inizio, un mezzo e una fine». Naturalmente è la composizione poetica a fare di un avvenimento qualsiasi l’inizio, la parte centrale o la conclusione di un’azione. In questa prospettiva la chiusura del racconto, così problematica nel romanzo moderno, costituisce il punto essenziale dell’arte della composizione. Vale lo stesso per l’estensione: è l’intreccio a conferire all’azione un perimetro, un limite e, per conseguenza, un’estensione.
«L’estensione che permette il rovesciamento dell’infelicità in felicità o della felicità in infelicità attraverso una serie di avvenimenti che si connettono secondo principî di verosimiglianza o necessità fornisce una delimitazione (horos) soddisfacente della lunghezza». Naturalmente quest’estensione non può che avere un carattere temporale: il rovesciamento richiede del tempo. Ma si tratta del tempo dell’opera, non del tempo degli eventi nel mondo. Non ci chiediamo cos’ha fatto l’eroe tra due ingressi in scena che nella vita sarebbero distanziati nel tempo ma che nella storia narrata si toccano. Solo necessità e verosimiglianza determinano l’estensione dell’esposizione, che è ridotta nella tragedia, più ampia nell’epopea e conosce la massima variabilità con il romanzo moderno. È sullo sfondo di questa esigenza di concordanza che si definisce, perlomeno nel modello tragico, la maggiore discordanza – il “rovesciamento” o mutazione del destino. Il colpo di scena, che è insieme contingente e sorprendente, è la tipica forma di rovesciamento nella tragedia complessa. La contingenza – cioè il fatto che uno specifico avvenimento avrebbe anche potuto svolgersi in un altro modo o non verificarsi affatto – si trova così in armonia con la necessità e la verosimiglianza che caratterizzano la forma generale del racconto: ciò che nella vita sarebbe un puro caso, senza rapporto evidente con alcuna necessità o verosimiglianza, nel racconto contribuisce all’avanzamento dell’azione. In un certo senso, la contingenza si trova ancorata alla necessità e alla verosimiglianza del racconto. Per quanto concerne l’effetto di sorpresa, che suscita lo sbalordimento dello spettatore, si trova anch’esso ancorato all’intelligibilità della storia narrata, a tal punto che produce nello spettatore la famosa purificazione dei sentimenti scaturita dalla rappresentazione che Aristotele ha chiamato catharsis.
La coerenza della storia; infine, tra la pura successione e l’unità della forma temporale che, al limite, può rovesciare o anche cancellare la cronologia. Ritengo che questa molteplice dialettica spieghi il conflitto, sempre presente nel modello tragico, tra la dispersione del racconto in episodi e la capacità di sintesi sviluppata dal processo di configurazione (la poiesis). L’identità del personaggio Per poter render conto dell’identità che qui ci interessa, quella del personaggio, cioè del supporto stesso dell’intreccio, dobbiamo riferirci alla costruzione dell’intreccio da cui il racconto ricava la propria identità. Come abbiamo visto, Aristotele non sembra aver preso in considerazione questo problema, tanto è occupato a subordinare il supporto dell’azione all’azione. Ma noi ci serviremo proprio di questa subordinazione. Detto in altri termini: se ogni storia può essere considerata come una catena di trasformazioni, da una situazione iniziale a una finale, allora l’identità narrativa dell’eroe non può che essere lo stile omogeneo di una trasformazione soggettiva in accordo con le trasformazioni oggettive che obbediscono alle regole di completezza, totalità e unità della costruzione dell’intreccio.
A cura di Esther Basile-Filosofa Istituto Italiano Studi Filosofici di Napoli
Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®


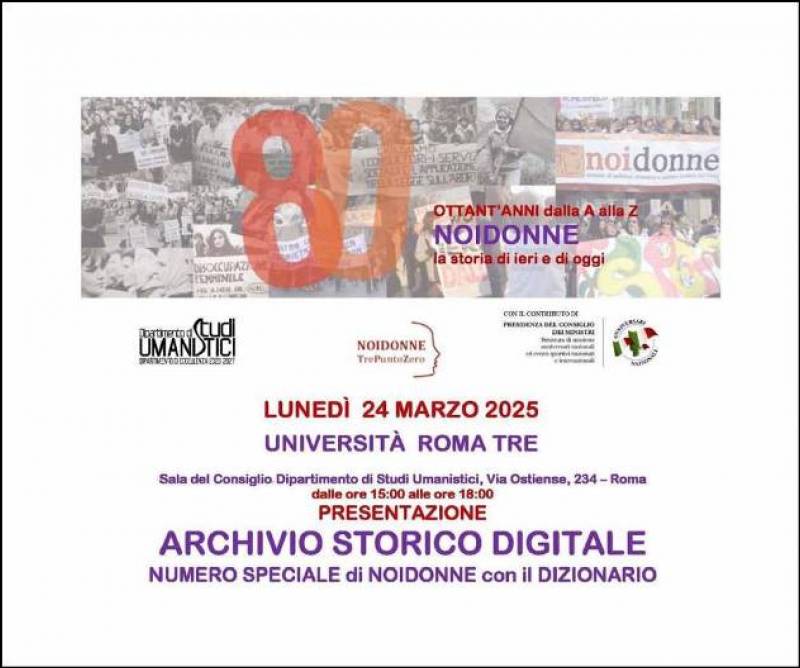

Lascia un Commento